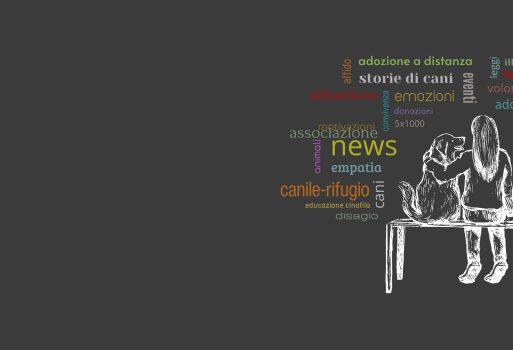Cos’è e come si contrasta. Le prime avvisaglie segnalate da Apaca già nel 2019.
Era il mese di aprile del 2018 quando nel corso di uno degli incontri informativi che Apaca aveva proposto ai bellunesi, il dott. Gianluigi Zanola, uno dei responsabili del Servizio Veterinario dell’Ulss 1 Dolomiti, aveva “profetizzato” che, nell’arco di breve tempo, i pappataci (nome scientifico Phlebotomus papatasi, detti anche flebotomi, papatacci e zanzare della sabbia) sarebbero arrivati anche in provincia di Belluno e con essi la leishmaniosi, una parassitosi temutissima per i cani, difficile da diagnosticare, con sintomi molto simili a quelli di altre malattie che colpiscono il cane, ma non così letali come, invece, questa patologia che, tra l’altro, ha un’incubazione che va da una trentina di giorni fino a 7 anni.
La stampa locale diede notizia delle prime due diagnosi di leishmania il 30 giugno 2019: si trattava di due cani che risiedevano a Canè di Limana e a Castion, una frazione del comune capoluogo, entrambi mai portati in zone infette fuori provincia e abituati a stare soprattutto in giardino. Della notizia si perse traccia, ma di casi rilevati di leishmaniosi si continuò a parlare anche negli anni seguenti, fino ad arrivare al 1° marzo di quest’anno quando, sempre la stampa locale, ha dato l’annucio del “primo caso autoctono” di leishmania, che ha ufficialmente allertato anche il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell’Ulss n.1, artefice di una circolare inviata il 24 febbraio a tutti i medici veterinari della provincia, invitati, d’ora in poi, a sollecitare i proprietari di cani e gatti all’opportuna profilassi antiparassitaria.
Non è dato sapere a che stadio sia la diffusione della leishmaniosi sul territorio (una ricerca dell’Ulss sarebbe certamente opportuna), ma il vettore (pappatacio) è presente e quindi da questo momento Belluno si unisce al lungo elenco di territori endemici e infetti, tra i quali quelli confinanti del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, da cui l’insetto, in ragione del cambiamento climatico in atto (mutamenti di temperatura e precipitazioni), è sconfinato, raggiungendo aree climatiche fino a qualche tempo fa non adatte al suo ciclo vitale.
E’ chiaro che si tratta di una malattia molto grave – tra l’altro, potenzialmente letale per il cane – ed essere consapevoli della sua presenza contribuirà a contenerne la diffusione, ma è anche vero che va evitato ogni terrorismo mediatico, perchè: a) la patologia – presente ormai da oltre un secolo nei territori (pandemici) costieri e collinari del versante tirrenico, ionico e del centro-sud e delle isole maggiori, e da alcuni decenni (in focolai di piccola e media entità) anche nell’Italia centrale, in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli – non sembra essere così diffusa tra i cani e men che meno tra gli umani (va utilizzato il condizionale perchè gli ultimi dati ufficiali risalgono a ben 6 anni fa e alcune recenti indagini fissano intorno al 18-19% l’attuale prevalenza media in Lombardia); b) ad essere colpiti continuano ad essere soprattutto (ma non solo ovviamente) i cani che la notte stanno all’aperto, dato che i pappataci, attivi da maggio a ottobre, operano soprattutto nelle ore crepuscolari e notturne, non amando nè la luce, nè le correnti d’aria (e quindi neanche i ventilatori di casa); c) la parassitosi non si trasmette nè da cane a cane, nè da cane all’uomo, perchè serve sempre un vettore e questo è il pappatacio che apprezza particolarmente le zone umide (quindi niente acqua stagnante, neppure nei sottovasi, niente rifiuti nè cumuli di foglie morte lasciati in giro); d) per diminuire drasticamente il pericolo di contrarre la malattia basta far dormire il cane in casa (che è, in ogni caso, una bellissima abitudine a prescindere dai pappatac!) e, se si dorme con le finestre aperte, dotandosi di zanzariere a maglie molto strette.
L’azione preventiva è senz’altro quella sui vettori, ma utili – anche se sembra non risolutivi – sono gli spray repellenti e i collari antiparassitari. Nello stesso tempo, l’obiettivo non potrà che essere quello di curare i cani malati (per salvare il soggetto e anche per evitare una diffusione dei patogeni attraverso i pappataci che pungono il soggetto infetto), tenendo monitorati anche i cani che sembrano in salute attraverso esami sierologici periodici (gli stessi che le migliaia e migliaia di cani trafficati e stallati dal Sud senza alcun ritegno e controllo avrebbero dovuto fare e che praticamente mai hanno fatto, moltiplicando in maniera esponenziale i serbatoi della malattia). E’ in commercio anche un vaccino, sulla cui efficacia esistono opinioni differenti: ma il medico veterinario di fiducia saprà sicuramente dare la risposta. Ed è quanto abbiamo già fatto e continueremo a fare anche noi di Apaca rispetto ai cani del rifugio che purtroppo dormono all’aperto tutto l’anno!